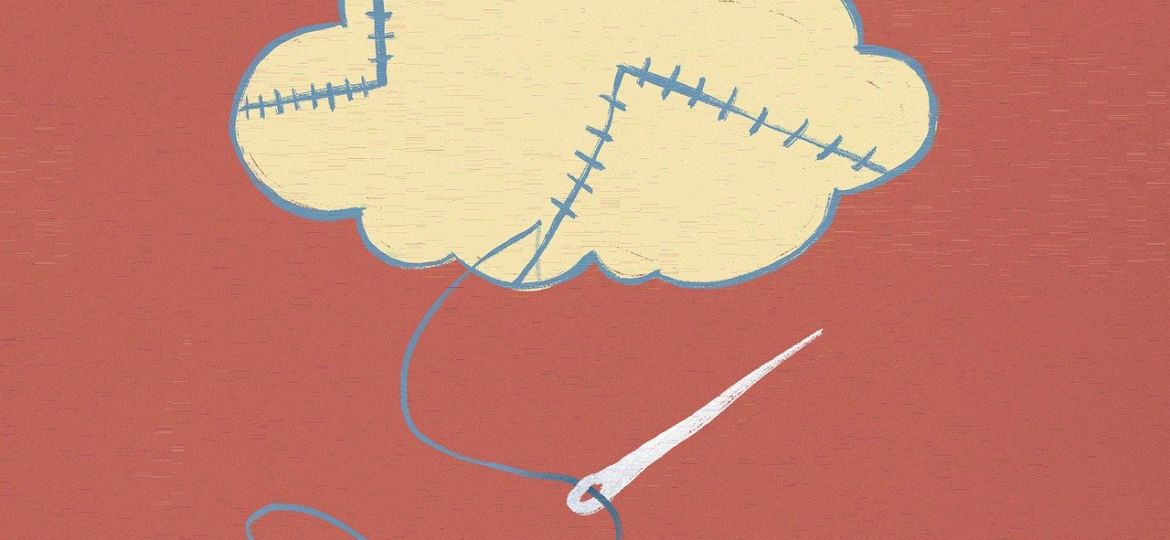
Nella vita religiosa, come nelle dinamiche delle comunità parrocchiali, il tema della fraternità risulta essere molto problematico. Anche laddove ci si forma per una vita di fraternità/sororità, si hanno continuamente situazioni problematiche, fino ad arrivare a confratelli o consorelle che non riescono a condividere più nemmeno un pasto.
Scivolare nell’esortativo è un attimo. ‘Occorre impegnarsi di più’, ‘occorre vivere più pienamente il proprio carisma e la propria consacrazione’, ‘occorre avere più carità o pazienza o misericordia’.
Ci si può anche appellare a questioni culturali, o antropologiche in quanto i giovani o le giovani di oggi non sono più quelle di un tempo. E questo in fin dei conti è vero. Antropologicamente non esistono più persone con le stesse caratteristiche evolutive o dinamismi intrapsichici di quelli che vivevano ai tempi dei fondatori di molti istituti religiosi. Il modo di concepire il rapporto con l’autorità, il rapporto con l’altro o l’ambiente o prima ancora con se stessi è profondamente mutato. Eppure mutati non sono certi modelli formativi o certi regolamenti, come se rappresentassero una dimensione trascendente e pura, a cui l’individuo deve solo configurarsi, indipendentemente da quello che è in quel tempo e in quel luogo. Si richiede una docibilitas ai regolamenti/Ratio Formationis più che allo Spirito. A titolo di esempio, il fatto che all’interno di uno stesso Istituto o Congregazione esistano stessi regolamenti di vita comune o di preghiera in parti diverse del mondo – Africa, Asia, America del Nord o del Sud, Europa – è molto strano se non improprio. In quanto, se il carisma è un organismo vivente, dinamico, che esprime la sua creatività a contatto con i territori e la storia, in linea teorica questa uniformità non dovrebbe avvenire. Costituisce più un impedimento al carisma, un impedimento allo Spirito.
Dovremmo anche chiederci se è ancora generativa la differenziazione e la distanza fisica dei corpi tra maschile e femminile, come un tempo era nella scuola o nell’associazionismo religioso. Rappresenta qualcosa di significativo e provocatorio per la realtà attuale o qualcosa di insignificante o addirittura contro-natura?
Il seguente capitolo analizzerà, alla luce delle tensioni introdotte nel primo articolo di questa serie, un modo infantilizzante alle relazioni e alla fraternità.
Oltre i verticalismi magici
“Il problema della fraternità deriva dalla povertà spirituale”. Un’affermazione che sento echeggiare sovente e che mi appare troppo facile. Sposta su un piano intimo e soggettivo una responsabilità relazione e inter-corporea.
Schiacciamento verticale rispetto all’orizzontale: non da intendersi come legame con il divino sopra quello dell’umano ma come consequenzialità automatica, magica, del secondo dal primo. Deresponsabilizzazione.
Si potrebbe affermare anche l’esatto opposto? “La povertà spirituale è determinata da una carenza di fraternità vissuta”. Se la spiritualità è divenire profondamente un essere relazionale, attraversato dall’Altro e dagli altri, allora anche questa affermazione sembra porre una questione seria. Nulla di nuovo sul fronte orizzontale.
Di questo abbiamo scritto nell’articolo ‘Sorelle e fratelli tutti in terra‘.
La filiazione integratrice: dal separare all’unire
Una fraternità senza padre non è una fraternità possibile. Il rischio di oggi è di sostituire la paternità con la fraternità. Restare nel ‘due’ divisivo. L’assenza del padre, figura dalla quale si è chiamati a separarci, non permette ai soggetti di individuarsi (A. Wénin).
Il padre è il terzo… la fraternità da sola resta nel ‘due’, polarizza, massifica escludendo. Vivere la fraternità/sororità come un Grande Fratello o una Grande Sorella genera una patina ideologica che ricerca rimedi magici e non umanizzanti.
Il padre è colui che esce per unire, cerca di re-integrare il figlio minore (Es) con il figlio maggiore (Super-Io): è l’Io unitivo. Sa che entrambi sono necessari per lo sviluppo e che solo in una tensione generativa si evolve verso l’adultità.
Il padre è colui che opera la circoncisione simbolica, il taglio, affinché il soggetto esca da se stesso e si apra al mondo, all’altro. È colui che chiede ad Abramo di lasciare la propria terra, i propri legami, le proprie proprietà e incamminarsi. È colui che chiede di amarlo più di suo padre e di sua madre, di sciogliere le dipendenze affettive genitoriale, e quindi di aprirsi nella libertà alle relazioni, alla vita. Altrimenti la relazione/fraternità sarà sempre vissuta come succedaneo affettivo per colmare la ferita/vuoto, ripetendo i possibili meccanismi disfunzionali dell’infanzia, o luogo proiettivo dove operare un incesto affettivo volto a colmare la propria mancanza, sostituendo il dono con il sopruso/abuso.
Il ruolo integratore del padre è quindi ciò che garantisce l’armonia delle diversità individuali, sottraendo queste ultime dalla violenza uniformatrice, addomesticante al sé o al regolamento. Siamo sulla tensione separare-unire. Lo schiacciamento sul separare porta all’infantile assorbimento dell’altro o alla distanza disi-compromettente. In entrambi i casi assistiamo ad una espulsione del soggetto dalla reciprocità che è alla base di ogni relazione adulta.
Uomo e donna separati?
Nel passato la divisione tra maschi e femmine avveniva sia nel servizio pubblico – come è stato nella scuola italiana fino agli anni sessanta -, così nell’istruzione cristiana e nell’associazionismo: scoutismo, oratori, Azione Cattolica. È ancora così nella vita religiosa, anche se alcune nuove forme tendono a unire e non dividere i generi, con il conseguente intervento di Roma che invia un commissario per valutarle ed eventualmente chiedere interventi correttivi. Corpi e sessi che si mescolano dentro uno stesso perimetro fisico. Il Vaticano chiede loro di mantenere separate e ben delimitati gli spazi fisici nel corso della giornata, separando uomini e donne in alcuni dei loro momenti di confronto, di preghiera, di fraternità/sororità.
Non voglio entrare qui in un giudizio sugli ordini religiosi femminili e di come sono spesso stati – e spesso ancora oggi sono – considerati rispetto al ruolo dei maschi. Servizi di pulizia, di accudimento di vescovi o sacerdoti anziani, in generale ruoli ancillari rispetto a quelli dei consacrati maschi. La questione è qui legata alla divisione, separazione tra i sessi. Un apostolato solo coniugato al maschile o solo al femminile, quanto è in grado di essere efficace? In grado di essere per tutti? Unire le sensibilità, senza uniformare ma mettendole in dialogo per generare un terzo. Una Chiesa narrata solo al maschile, che non entra nel due, non è in grado di accedere al terzo.
La scissione in due apre ad una più decisiva creazione. Il mondo riconosce così una differenza definitiva, prima obliata, irriducibile: “quello che divide l’essere umano stesso senza superamento possibile della scissione. Mai costituzione dell’Uno, dunque, ma costituzione di due mondi aperti in relazione l’uno con l’altro, e che ne generano un terzo come opera comune, come spazio-tempo da condividere (Irigaray, La via dell’amore, pag. 13).
Per compiere il destino dell’umanità, lumano-uomo e l’umano-donna devono compiere ciascuno ciò che sono e nel contempo realizzare l’unità che costituiscono (Irigaray, Ibidem pag. 73).
Unire è proprio riconoscere tale differenze originaria. Mentre l’aver fatto derivare l’unità da un solo ente/essere è stato negare la differenza costitutiva di questa unità. L’unità non può essere data da una sola parte ma nemmeno dal suo opposto. Il maschile e il femminile non sono uno l’opposto dell’altro o l’inverso o il contrario. Sono differenti. Sono due poli di un essere umano unico che in realtà non esiste, se non nella concettualizzazione maschile che lo ha storicamente caratterizzato con le sue fattezze, applicandovi alcune aggiunte e mancanze.
La Legge che libera: evitamento del cerchio
Il Padre è la legge. La Legge non sono i regolamenti, non è la Ratio. La Legge non controlla, la Legge custodisce e libera. La Legge impedisce la morte del soggetto nel suo ridursi al pulsionale, nel suo rispondere ad impulsi interni non maturi, non orientati. E garantisce lo stare insieme, la società. Custodisce dal delirio di onnipotenza insito in noi dal giardino dell’Eden. Non tutto si può possedere, non di tutto si può godere e bramare: origine del divieto universale dell’incesto.
Nell’uomo c’è una dimensione interiore, una dignità profonda percepita come coscienza di libertà che, scrive Zundel, entra in tensione con i precetti e le leggi morali che sembrano imporsi dall’esterno. Per quanto confusa e passionale sia questa presa di coscienza, ha comunque a che fare con l’inviolabilità del soggetto, e ogni tentativo esterno di sottometterlo ad una costrizione è visto come profanazione di questa realtà interna. Tuttavia, secondo l’autore, l’uomo pur prendendo coscienza della sua dignità e pur reagendo alla sua violazione non sa fondarla. In quanto egli non è origine di se stesso. L’uomo tende a liberarsi da tutto ciò che potrebbe impedirgli di essere l’origine dell’io mediante il quale si afferma. Questa conquista di sé, cui tutti siamo chiamati, è quanto di più difficile esista. Molti non se ne rendono nemmeno conto e non se ne preoccupano. C’è un ‘no’ deciso secondo l’autore sul sentire profanata la propria soggettività ma non c’è un altrettanto ‘sì’ chiaro rispetto alla volontà di costruirsi (Zundel, Quale uomo e quale Dio. Esercizi spirituali predicati a Paolo VI e alla Curia Romana, 36-41). Qui la funzione della legge come terzo. Una legge in grado di regolare e orientare quell’altra legge inscritta nelle membra (Rm 7, 18-25).
Una legge non pensata per ostacolare o frustrare un godimento ma per strutturare un desiderio. Proprio l’inversione di significato che opererà il serpente nel giardino celeste, per condizionare l’azione della donna. La libertà diviene così la trasgressione. Nella vita religiosa non sorprendono allora alcuni comportamenti devianti e non rispettosi della fraternità o degli altri: un certo individualismo, la non partecipazione ad alcune proposte o richieste, il doversi distinguere. Forme di protezione o tutela di quella soggettività, di quella personale dignità che si sente violata, associando alla legge non la funzione di rottura del cerchio autoreferenziale ma di accerchiamento soffocante e limitante. Sintomi d’infantilismo.
Non è la Legge come descritta finora che porta al peccato, è l’esortazione morale a starvi lontano che lo rende desiderabile. Porre l’attenzione sul peccato è renderlo desiderabile. È dargli importanza rispetto al bene possibile: Rom 7, 5.7-9. Collin ribadisce questo concetto: “Dovremmo chiederci quanto la stessa struttura morale del cristianesimo genera la pulsione verso il peccato e il desiderio di esso, non orientandolo diversamente ma aumentando la spinta pulsionale” (Collin, Il Vangelo inaudito).
Il ‘sistema’ dottrinale e disciplinare non va visto come un apparato rigido, altrimenti per il teologo Maurice Bellet avviano un processo di irrigidimento della vita.
E non sono la disciplina e la dottrina in quanto tali ad esserne la causa, ma la pretesa di garantire, attraverso un sistema in cui esse si irrigidiscono, la vita stessa. E, quando si tratta della fede in Cristo, di sostituire di fatto il Vangelo, annuncio di gioia, con un insieme rigido di prescrizioni, abitudini e costrizioni che dovrebbero dargli consistenza nella realtà. La sfortuna è cominciare con ‘devi’. Devi credere perché è obbligatorio. E perché è obbligatorio? Perché lo dice la fede. Cerchio perfetto. Eppure la prima parola dell’amore non è ‘devi’ ma l’amore stesso. (Bellet, Le Dieu pervers, 12, traduzione e corsivi miei).
La legge custodisce la fraternità ma non la garantisce. Senza l’amore libero non c’è relazione che tenga. Non si può divenire fratelli per legge, così come non basta essere padri o madri perché si è genitori. Se la legge protegge dalla morte l’amore promette che la vita continui. Eppure il rischio più grande è che diventi legge.
L’amore è la peggiore di tutte le leggi, scrive Maurice Bellet. “La legge dell’amore è la peggiore di qualsiasi altra legge, non lascia alcun riparo né tregua, e proibisce persino la conoscenza: perché la cosa più sicura è che l’uomo sia cieco riguardo al proprio desiderio, così sarà meno tentato di soccombervi” (Bellet, Ibidem, 34).
Accogliere l’incompleto in terra.
Nella genesi tutto inizia con Caino e il fallimento della fraternità. La fraternità diviene un progetto etico, escatologico, non più un semplice dato della natura. Non si nasce fratelli, lo si diventa. Come abbiamo già scritto sopra, uscire dal nostro involucro egoico chiede qui in terra un’autorità, una legge paterna, un taglio/circoncisione.
Un taglio alla circolarità narcisistica. Una rottura instauratrice… un taglio che generi una discontinuità, un mancante in grado di permettere il desiderio e la crescita.
Il fratello/sorella non basta. Può alimentare i miei fantasmi, divenire sfogo proiettivo delle mie fragilità oppure soggetto da cui proteggermi e tenermi distante. Non sentirmi figlio, non sentirmi amato e amabile, proietterà sull’altro la mia trave interiore facendomi soffermare sulla sua pagliuzza.
Il sentirmi mancante, l’accedere al mio vuoto ombelicale, può infatti divenire origine di una ricerca matura e realistica dell’altro/a oppure una ricerca spasmodica di copertura di quel vuoto a danno degli altri, anche se camuffato da belle parole e buone intenzioni.
Vuoti a rendere: l’opportunità del non chiuso
Spesso mi arrivano richieste formative in merito al tema della vita fraterna, di fronte a difficoltà e tensioni che si manifestano nelle comunità. Potremmo chiederci se si può formare alla fraternità o se è la fraternità che ci forma. Altra tensione preziosa se consideriamo entrambe le possibilità. Troppo spesso l’attenzione è posta però solo sul primo polo, quello di formare a… e questo porta ad un irrigidimentare la gestualità, a segnare a livello corporeo il soggetto oggettivizzandolo dentro un modello; al dispiegamento di immagini e delle loro sequenze nel campo visivo e percettivo della persona, penetrando nel suo linguaggio, colonizzando la sua capacità di simbolizzare la realtà. Questo è rassicurante e controllabile, ma infantile e inefficace. In quanto la formazione dovrebbe restituire libertà all’uso del corpo, ai gesti relazionali intra e interpersonali, allo sguardo su di sé e sugli altri. È un esitare più che un conformare.
Di fronte ad una madre generale che si lamentava dello scarso senso di responsabilità da parte delle suore più giovani, etichettandolo come egoismo tipico delle nuove generazioni o legandolo a motivi culturali per via della loro origine extra-europea, ribadii che la responsabilità nasce dalla libertà. Dal generare vuoti nei contesti formativi e di vita comune. Solo da quel vuoto può nascere una risposta, solo da esso si può chiedere all’altro di re-spondere. Una vita tutta regolata da orari, dal suono di un campanello, da comportamenti richiesti, necessari a far esalare l’ultimo respiro ai propri desideri, pulsioni, istinti, non consente responsabilità. Al contrario, favorisce la ricerca di aree grigie dove potersi rifugiare, dove poter contattare la propria profondità negata oltre la scorza spessa dei doveri e dei regolamenti. Favorisce la possibilità che il desiderio e il piacere represso si possano manifestare con la massima violenza verso un confratello o una consorella, o verso una figura gerarchicamente inferiore nella forma di un abuso di coscienza o di potere.
Un sistema chiuso, totalizzante, non genera soggetti responsabili. E più cerca di mettere sotto la luce i comportamenti di tutti, per controllarli e regolamentarli, più accresce gli spazi di fuga, di evasione, di violenza fratricida.
Un sistema è dotato di appositi dispositivi di controllo e repressione, che il soggetto interiorizza. Nel nostro caso è in grado di attivare nei soggetti un censore interno potentissimo, il senso di colpa, volto a frenare e limitare l’atto o il pensiero deviante. Ma questo si pagherà poi duramente, portando le persone a reazioni o regressive o aggressive. Il sistema chiuso dietro la sua affidabilità e linearità presenta la sua ombra.
Un sistema aperto prevede e favorisce l’imprevisto, il non già determinato. Non si legittima con un regolamento ma dal poter rintracciare negli atti di vita un senso. Per fare questo è necessario affiancare ai vuoti – dove i soggetti sono chiamati a mettere in gioco la formazione ricevuta e la propria personalità e libertà -, tempi e spazio di narrazione di quanto esperito. Solo così anche l’errore diviene strumento di crescita e apprendimento, permettendo al soggetto di divenire adulto in quanto in grado di corrispondere alla realtà, non condizionato dall’esterno. Altrimenti l’errore è solo condanna, è richiamo al regolamento e quindi alla sua continua dipendenza che chiede non vita ma solo ripetizione.
Faccia a faccia e non di fianco
Esistere significa ricevere da altri l’esistenza. Ma significa anche, uscendo dal’indifferenziazione, provocarne le reazioni; vuol dire essere accettati aderire ad una società, ma anche prendere posizione nei suoi confronti e incontrare dinanzi a sSè, come un volto illeggibile e ostile, la presenza di altre libertà. Chi sfuggisse da questo faccia a faccia, non per questo eviterebbe la paura, inseparabile da ogni sconto, ma rinuncerebbe ad essere, affermando al vento un diritto che sarebbe incapace di far riconoscere. […] Non si vive senza gli altri. Questo significa che non si vive senza lottare con loro. (de Certeau, Mai senza l’altro, 43-44).
Dall’origine, dalla Genesi, il rivelarsi dell’altro rappresenta un faccia a faccia ineliminabile e connaturale alla nostra esistenza. Questo apre alla questione del conflitto, un termine che in alcuni contesti ecclesiali è ancora visto con sospetto, con paura e in alcuni casi viene bollato come peccato. Considerare peccato il conflitto comporterebbe di vivere in un inferno continuo, senza via d’uscita. Ho presente il senso di colpa e l’angoscia impressi sul volto di chi era stato formato sulla base di questo principio contro-natura.
Nel mondo sono proprio le culture educative a-conflittuali e rigide quelle che più facilmente si ritrovano all’origine delle guerre. Si tratta di modalità educative che tendono ad eliminare il valore della differenza e del conflitto che è il vero bonificatore delle proiezioni persecutorie. Imparare a ‘stare’ nel conflitto invece permette di evitare di spostare fin maniera paranoica sull’altro, o sugli altri, quelle che sono in realtà le proprie pulsioni interne (D. Novara, La grammatica dei conflitti, pag. 33).
Pierre Clavarie, domenicano e vescovo in Algeria, ucciso da una bomba nel cortile del vescovado e beatificato da Papa Francesco nel 2018, ribadisce tale concetto con forza e lucidità nel suo Piccolo tratto dell’incontro e del dialogo. Il fatto di vivere in una terra dove i cristiani rappresentano una piccola minoranza, ha rappresentato per lui sia un rischio che un’opportunità. Se inizialmente racconta di essersi a lungo comportato come se l’essere umano fosse caratterizzato dall’avere dei punti in comune e che comunicare e ritrovarsi sia naturale, ha poi dovuto prendere atto dell’esatto contrario. Questo a partire già dal diverso modo di percepire la realtà mediante i nostri sensi attraverso i quali costruiamo il nostro mondo. È giunto così ad affermare che un incontro e un dialogo necessariamente debbano iniziare dal riconoscimento delle differenze e del conflitto insito in esse.
In questo consiste anche l’azione liberante di Gesù. Uomo libero che interpella l’altro per farlo uscire dalla ‘sua bolla’ autoreferenziale. Dal poter bastare a se stesso. Dalle proprie convinzioni e credenze che tendono ad addomesticare l’altro e vederne le somiglianze per portarlo a sé, sedurlo, o in caso contrario respingerlo. Uscire dai propri confini per entrare a contatto con il Vivente.
Se l’altro di fronte a me mi vede senza la mia differenza, come un medesimo, annulla lo speculare o lo speculativo. “Torno a me immutato in una Storia e in un mondo compiuti. La mia immagine ideale è allora rinviata nell’aldilà, in Dio, che mi fa andare verso il differente, la differenza, senza poterla sperimentare”. (Irigaray, La via dell’amore, 52). In quanto Dio è visto come causa fondamentale dell’unità e del pensiero, in grado di assicurare l’unità del tutto essendo esso stesso autosoddisfacente, causa sui. “Un Dio programmato dall’uomo e non realmente trascendente a lui” (53).
Per de Certeau i conflitti hanno addirittura un significato religioso, in quanto possono portarci a riconoscere gli altri e aprirci una via umile ma reale verso la riconciliazione, dentro la contingenza del reale. Ci purificano dai nostri assoluti ideologici, ci fanno uscire dall’astratta universalità delle idee chiedendoci di operare scelte concrete, dentro interessi particolari.
La pesantezza dell’amore
Non siamo capaci nemmeno a toccarci con le parole. Rispettando la trascendenza dell’altro, saper andare oltre le separazioni senza cadere nella confusione-fusione, senza essere presi dall’angoscia dell’indefinito. Parole che toccano – termini sensibili, direbbe la filosofa Irigaray -, che chiedono di superare il modo in cui in origine siamo stati toccati, che purifichi e liberi le parole di cui siamo stati fatti oggetto più che soggetto, minando la sorgente del nostro essere.
Toccare lasciando uno spazio, lasciando una libertà. Chiudere per permettere un incontro ma senza rinchiudere. Trattenersi senza trattenere. ‘Noli me tangere’. Non toccarmi, non trattenermi, dirà Gesù al sepolcro verso la mano tesa di Maria di Magdala. “L’amore e la verità toccano respingendo” (Nancy). Il risorto che chiede che l’evento della novità della vita non sia addomesticato dalla nostalgia che ancora segnava le guance della donna. Toccarsi nel profondo senza prendersi. Il luogo dell’amore è proprio in questa distanza.
Il luogo dell’amore (che chiameremo ‘simbolico’) è la parola, e la parola instaura la distanza nel momento stesso in cui unisce”. La distanza che permette di evitare la fusione possessiva o la padronanza del volere e del dovere. La distanza che permette la libertà. Una libertà che vissuta dentro la nostra ambivalenza, dentro la responsabilità, non è il fantasma aleggiante di un’idea, di un valore. “La libertà dell’amore è nella pesantezza. Essa deve lavorare, attraversare lo spessore” (Bellet, L’amore lacerato, p. 25). È fatta di vuoti, è edificata dalle perdite, dall’uscita dal cerchio rassicurante della morale o appagante del godimento, dalla rinuncia al verticalismo che metta in ordine quello che è ambiguo e tutto compenetrato, dalla rinuncia a sovraccaricare le relazioni umane di una volontà di pienezza che risulterebbe insostenibile. Uscendo da questi infantilismi si acquisisce la sapienza dell’amore, si segue l’esempio di Gesù acquisendo la nostra originalità. In quanto l’originale si realizza: l’originale di ognuno di noi non è in un inizio mitico, in un’inscrizione predeterminata, ma si manifesterà nei frutti attraverso l’esercizio di questa libertà di amare.
