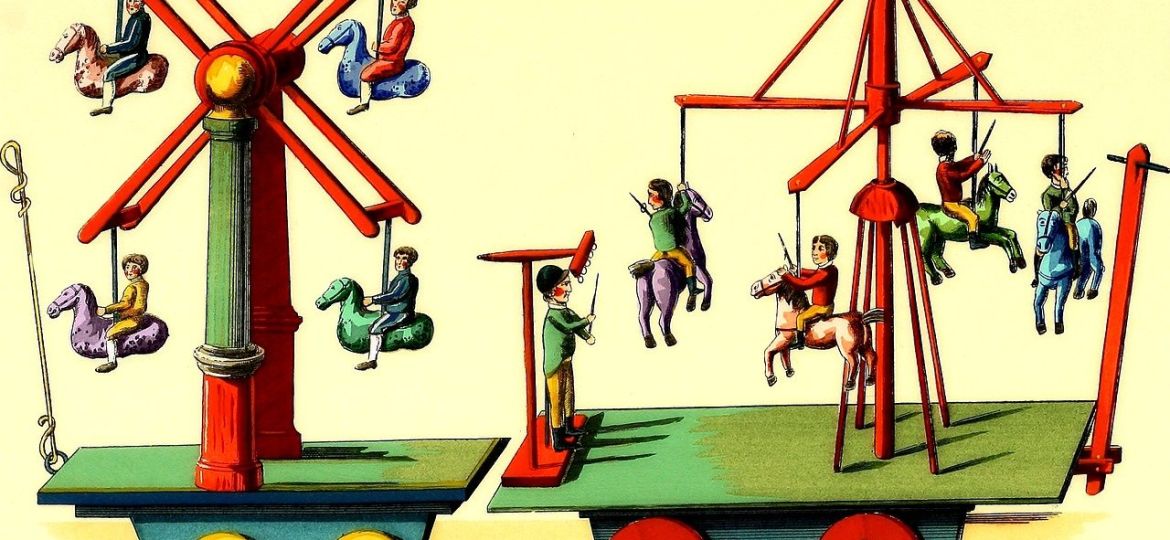
In questo articolo non desidero trattare temi di psicologia o di pedagogia applicati al contesto ecclesiale. Il termine infatilizzazione è qui attribuito ad una cultura, a mio giudizio, diffusa nella Chiesa a vari livelli: formativo, decisionale, relazionale, linguistico, simbolico, sessuale… è una cultura interna all’alveo ecclesiale che porta i soggetti che ne fanno parte a non acquisire una piena autonomia e libertà; qualora costoro siano chiamati a ruoli di governo o di responsabilità, si notano imbarazzanti atteggiamenti elusivi, o collusivi o manipolatori. Restano dentro un piano di indefferenziazione, che non significa la perdita di tratti caratteristici – sarebbe solo osservare il superficiale – ma di incapacità a distinguersi da una cultura data, di generare degli strappi, di assumere una gestualità, una corporeità, una ritmicità altra da quella dominante da cui mantengono una dipendenza. Quei membri della Chiesa che apparentemente si distanziano o sembrano distinguersi dall’istituzione, in realtà non fanno che esaltare maggiormente i tratti di questa cultura e trovano in essa una loro forma di giustificazione. Qui schiavitù e libertà coincidono.
Questa infantilizzazione si manifesta non nei discorsi pubblici o negli scritti ma nei gesti, nella reazione di fronte ad alcuni eventi, all’interno di relazioni ambivalenti e caratterizzate da tensione, nei manifesti o nelle mail, nella gestione dello spazio fisico, nella messaggistica, nei riti e nelle consuetudini, nell’uso di alcuni vocaboli.
Tratteggerò l’argomento in più articoli. In questo mi sta a cuore porre alcuni fondamenti filosofico-teologici che fanno emergere in filigrana il sistema di infantilizzazione della Chiesa attraverso l’analisi di alcune tensioni sottostanti a questa cultura. La dimensione più prettamente pastorale sarà trattata nei successivi articoli: proprio analizzando il modo di porci all’interno di queste tensioni mostreremo come l’infantilizzazione sia presente nelle nostre rappresentazioni del cosmo, di Dio, dell’uomo, delle relazioni di fraternità/sororità, dell’apostolato, della formazione.
Il discorso non riguarda i solo consacrati, coinvolge anche i laici nel momento in cui si trovano a svolgere un servizio nella Chiesa. Possono essere degli affermati manager sul piano professionale ma, quando si trovano dentro il recinto ecclesiale, come pecore assumono la cultura interna infantilizzante che caratterizza questo luogo.
Le tensioni sottostanti l’infantilismo ecclesiale
Come nella teoria delle opposizioni polari di Guardini, le tensioni sono formate da due poli opposti ma non contraddittori. Entrambi i poli sono validi e vitali, sfuggono dal giudizio giusto/sbagliato, bene/male, ma chiedono un discernimento in termini contestuali: cosa è opportuno oggi, kairos. Nell’analisi della cultura ecclesiale pongo in evidenza cinque tensioni:
Separare ——————————— Unire
Verticalità —————————— Orizzontalità
Circolarità —————————— Discontinuità
Chiuso ——————————— Aperto
Di fianco ——————————— Di fronte
Per infantilizzazione, intesa come diffusa cultura infantile nel porsi di fronte alla realtà, indichiamo uno schiacciamento sul lato sinistro dello schema, sulla serie separare-verticalità-circolarità-sistema chiuso-di fianco. Assocerò ad ogni tensione una dipendenza che ne determina l’infantilità soggiacente e alcune parole chiave che ne determinano le narrazioni auto-giustificative.
Quando il separare è superiore all’unire: il potere ordinatore
Infantilismo è il solo semplificare, distinguere, separare, profilare, controllare, mantenere una base di sicurezza. È non accettare l’ambiguo, l’incompleto, il non definito. È possedere, com-prendere, assimilare. È potere ordinatore.
È il potere del due. Il potere che distingue, che non consente confusione. È più il potere dell’odio che dell’amore, direbbe Empedocle – eppure siamo chiamati a stare nella tensione e non nel dualismo. L’amore compromette. Ordinare, profilare genera quella distanza utile per dire: ‘non io’, ‘non mi riguarda’, ‘non dipende da me’, ‘ è così’; oppure, al contrario: ‘io sono così’, ‘non posso essere diversamente’, ‘non posso farci nulla’.
È l’arte semplificatoria che fa scambiare l’essenzialità funzionale con l’essenzialità valoriale. Fare meno non è fare il meglio, generare più vita o più bellezza. Un fiore può non apparire essenziale per il fare prestazionale ma non è così per l’essere dell’innamorato.
Seguiamo la logica della semplificazione, la logica che è stata della scienza classica: causa-effetto, sostanza, necessità, cosa in sé… che esprimono bene la volontà di potenza che l’uomo ha impresso sulla realtà per finire poi di perderla – disperderla. Semplificare può tradursi nel rendere un organismo da complesso a complicato. Allungare la catena di comando, creare commissioni, organi secondari specializzati, mansionari più dettagliati. Andando verso l’immobilismo e l’incapacità di cambiare ed essere flessibili di fronte ad una realtà in profondo mutamento.
Distinguere per un confronto dialettico e non dialogico. È possedere la posizione dell’altro, comprenderla per farla propria e spossessarlo da se stesso. Ma dalla dialettica non emerge un senso. È l’anticamera dell’oblio.
L’infantilismo qui si lega ad una dipendenza dal senso di sicurezza. Questo piega il soggetto sul polo del dividere ed ordinare. Questo permette al soggetto di generare un discorso dove potersi rifugiare, starsene tranquillo. Parole guida: semplicità, essenzialità, specializzazione, organigramma, ruoli e compiti.
Verticalità su orizzontalità: la paura della responsabilità
Aiutare il soggetto a coltivare la sua vita umana nella sua generatività e nella sua crescita dipende da due dimensioni: verticale e orizzontale. Siamo di fronte ad una seconda tensione: tra verticalismo e orizzontalismo, trascendente e immanente, leadership e partecipazione, gerarchia e corresponsabilità.
“La nostra cultura ha privilegiato la verticalità, il rapporto all’Idea assunta come vertice di riproduzioni approssimative, il rapporto al Padre, al capo, al Tutto-Altro celeste. La relazione con l’altro, qui e ora presente accanto o davanti a me sulla terra, è stata poco coltivata come dimensione orizzontale del divenire umano” (Irigaray, La via dell’amore, 98).
Il verticalismo è rassicurante. Deresponsabilizzante. Delegante: a Dio, al superiore, all’esperto, alla pianificazione. Il verticalismo può sfociare in paternalismo o maternalismo. Spazio di regressione dove rifugiarsi per non dover fronteggiare il reale. Per la fatica a tollerare la frustrazione. Tornare a dormire nella famiglia di origine, nella propria cameretta. La madre! La madre superiora! La Madre Chiesa! Maria madre! Dall’altra parte abbiamo il Re, il re dei Re, il Re dell’Universo.
La psicanalista Wolff scrisse come tutto l’impianto Mariano e l’immagine di Chiesa Madre, rischia di far diventare i suoi servi dei castrati. Come mostra la teologa e psicologa, l’uomo che resta infantilmente legato alla madre viene soprattutto privato della sua potenza maschile. “L’odierna presa di posizione contro il celibato non è da intendere principalmente nel senso della morale, ma come protesta contro il cosciente mantenimento del legame materno, contro il non-dover diventar adulti” (Wolff, Gesù, la maschilità esemplare, 233).
Oltre alla maternità e alla paternità, presenti e indispensabili anche nel mondo animale, esiste un rapporto all’altro diverso. Un piano orizzontale. “Andare verso l’altro, accoglierlo in sé, aprono dimensioni non verticali nel rapporto all’umano e al divino”. (Irigaray, 101).“Questo ha limitato a lungo il nostro modo di concepire le relazioni e la possibilità di relazioni con l’altro che chiedessero di uscire dal proprio mondo e non assoggettare l’altro a sé e ad esso” (Irigaray, 56). La circolarità tra i due ruoli di padre e madre chiara alla dialettica, secondo la filosofa, oblia ogni possibilità di cominciamento.
Un verticalismo esercitato senza una familiarità con l’orizzontalità, sia nelle relazioni che nel governo che nella vita spirituale, è carico di soprusi, abusi psicologici e pastorali. Impedisce di vedere e di lasciarsi vedere. Soprattutto, tende ad un farsi forte con i deboli, senza preoccuparsi della loro crescita. È sostegno dello status quo anche quanto esso non ha più fondamenta, non trova più corrispondenza con la realtà circostante. Oppure è delega assoluta e fideistica, o formale e di facciata per poter occupare le zone grigie che la situazione garantisce, al fine di trarne una qualche soddisfazione o ritorno personale.
Si evidenza qui una dipendenza dalla paura della vulnerabilità che spinge il verticale sull’orizzontale. Porsi in cima (pastore/lerader) o in fondo (gregge/follower) al modello verticale protegge dal mostrarsi. Parole: analisi, piano, programmazione, progetto, disegno, provvidenza, madre, pastore, figliuolo/a, padre/madre.
Circolarità superiore alla discontinuità: la visibilità totalitaria
La circonferenza e la circolarità si contrappongono alla frattura e alla discontinuità, il prevedibile e il ripetibile al divenire e all’inaudito, al non ancora udito, obbedito.
Il cerchio garantisce la linearità, la ripetizione, la piena visibilità. Non ci sono increspature nel suo profilarsi nel tempo, non ci sono insenature o rientranze nelle quali sostare o rigenerarsi. È il dominio del visibile e del nominabile. Come scriveva il teologo e poeta Ruben Alves: ‘La piena visibilità è totalitaria’. Vista e udito sono stati eletti nella nostra società come i fedeli alleati nella relazione con il reale, a scapito degli altri sensi fisici e interiori.
“Il cerchio essendo già chiuso: in ogni punto, inizio e fine coincidono, ma a prezzo di un abisso”. (Irigaray 18). Alla circolarità della sfera papa Francesco opponeva il poliedro. L’irregolarità, la disunità armonizzata da un centro condiviso.
Il dominio del cerchio avviene tramite il potere del logos. Il teologo gesuita Michel de Certau sosteneva come l’esperienza sia sempre preceduta da una parola. Questo comporta che la nostra esperienza sensibile e intellettiva è vissuta già dentro un abito – o ‘habitus’, à la Bourdieu – che ci è stato fatto indossare.
Uscire dal cerchio significa uscire da questo potere, indica la necessità della costruzione di una parola nuova, un’inedita produzione alla luce di uno spazio/frattura che non assorbe, ascoltando l’altro come altro. È un rinascere dall’altro/Altro, un cominciamento. È questo Altro il punto da cui si dispiega il nostro dire, non assoggettandolo ad un discorso che lo precede, anche se questo potrà costituire il contatto iniziale, ma riconoscendone la sua differenza e peculiarità in grado di generare un possibile sommovimento nell’intendere e intendersi.
Il discorso, come abbiamo detto, nella sua perfetta circolarità oblia l’esperienza vissuta. Anche nelle pratiche si rischia di non intravedere più quel senso profondo che le aveva poste in essere. Direbbe il filosofo Deleuze: una ripetizione continua, una concatenazione di gesti che si riproducono senza alcun possibile scarto, portano a perdere il contatto con quel senso trascendentale che ne era all’origine. Nella prassi ecclesiale sono innumerevoli i gesti o le pratiche che possono essere annoverata in questa lista, di cui il soggetto che le agisce non riesce più ad operare una prensione sul senso iniziale.
La circolarità si impossessa della mente, del corpo, del tempo. Tutto è alla luce. Nessuna notte oscura da attraversare. Perché anche il buio e l’oscuro possono essere mostrati in tinte luminose, anche il demonio può mostrarsi da angelo della luce: inquinamento luminoso.
Uno schiacciamento sul cerchio, sulla continuità rispetto alla discontinuità, rivela una dipendenza dalla paura dell’abbandono. Del non ritorno. Del restare soli. Parole chiave: tradizione, eredità, conservazione, fedeltà, tradimento, ripetizione, chiarire, spiegare, insegnare, destino, progetto di Dio.
Sistema chiuso su sistema aperto: il regno della noia
Un sistema chiuso è un sistema ordinato, regolamentato, dove le persone operano dentro gruppi omologati, specializzati in un servizio. Vige un principio di iper-determinazione, in nome dell’ordine e del controllo, che inibisce ogni via sperimentale, ogni sussulto personale.
Si basa su due principi: l’equilibrio e l’integrazione (Sennet, Progettare il disordine). Ci sono entrare ed uscite di energia, di risorse, di investimenti… e la sfida e l’impegno è cercare di tenerle in constante equilibrio. È un sistema pensato per essere integrato: ogni sua parte ha un posto nel progetto complessivo; la conseguenza è di spazzare via le esperienze che spiccano perché sono controverse e disorientanti. Tutto va nel rispetto del progetto o piano pastorale, attraverso parole ‘educate’ ma in grado di gettare il sospetto su ciò che non si integra, facendo in modo che nulla si distingua. L’enfasi sull’integrazione scoraggia la sperimentazione.
La sovra-determinazione determina anche la fragilità di questo sistema. Lo rende inadatto al cambiamento, incapace di flettersi alle esigenze del momento in quanto rigido.
Ogni elemento ha una sua funzione data che non può cambiare. È il regno della ripetizione, della noia. Se prevale oggi una considerazione sulla possibilità di partecipazione nella Chiesa è proprio questa: è una realtà noiosa, per nulla attraente.
Il sistema chiuso opera velocemente e per questo necessita di essere chiuso nella forma: ogni elemento presente in esso deve poter essere quantificabile, determinato, per equilibrare e ben integrare in tempi veloci.
È un modello non solo noioso ma anche stancante, e le due cose sono spesso connesse. Perché non si sta parlando della sola stanchezza fisica che deriva da un agire orientato alla missione. Qui si parla di una stanchezza che, come descrive la teologa Guanzini: “non parla, non vede e manca di tatto” (Guanzini, Tenerezza. La rivoluzione del potere gentile, 52). Una fare privato dell’essere. Un ripetere privato del desiderio e senza vocazione, che toglie il respiro, la capacità di dirsi e offusca lo sguardo. Il soggetto, impedito di simbolizzare il suo essere/fare è indotto alla violenza abusante – nelle sue molteplici forme – distaccato dal suo sé profondo e lasciato alle sue pulsioni.
“Si ha bassa intensità affettiva e alta spregiudicatezza istintiva, si espandono territori di sensibilità estraniate e solitarie, senza linguaggio e senza compagnia, ma colmi di domande inespresse e di multiformi euforie” (Guanzini, 58). Come sottolinea la teologa, questo indebolimento progressivo del sentimento della vita, causato dall’operatività e dall’iperproduttività, non si origina da una sensazione di mancanza, ma dalla mancanza della mancanza. Un eccesso che va per aggiunte invece che per sottrazioni, quando la dimensione spirituale è sottrattiva, in quanto sgorga dal desiderio, dal vuoto incolmabile dell’altro/Altro. “Tale eccesso di pieni e povertà di vuoti non è terreno fertile per il desiderio, che vive del limite e della mancanza. […] Una disposizione cinico-scettica del mondo razionale adulto” (Guanzini, 62).
Un sistema chiuso è impedito al dono. In quanto si concentra sullo scambio e il contraccambio, sull’oggetto e non sul simbolo nella sua piena polisemicità. Si concentra più su ciò che si ha che su ciò che si è e non si è grado di possedere, in virtù del godimento che del desiderio. Si basa sulla potenza che tende all’onnipotenza. E possedere è più facile e semplice che amare. Diverso è spossessarsi, agire la propria impotenza. Il sistema chiuso tende a separare l’uomo dalla sua impotenza in quanto lo predispone ad agire, a compiere, alla prestazione. Il mantra sociale è ‘si può fare’, ‘è possibile’, ‘fallo!’, come se fosse l’uomo l’artefice del suo destino, e non agisse all’interno di forze di cui non ha il controllo. Tanto che il ‘poter non fare’ diviene una forma di resistenza al sistema chiuso. Un modo per riappropriarsi di ciò che si è perso: la propria capacità di impotenza (Agamben, La mente sgombra).
Un sistema aperto prevede l’incontro inaspettato, la scoperta casuale, l’innovazione… Si libera quindi da equilibrio e integrazione. Difende la diversità e la dissonanza senza avere l’ansia infantile di ordinare e definire tutto. Il sistema aperto è in continuo divenire ma si muove lentamente, lasciando libertà ad impulsi che sorgono dalle situazioni. La lentezza del processo non corrisponde alla velocità del buon funzionamento (integrato ed equilibrato). In un sistema aperto gli elementi che lo compongono non sono schiacciati dentro una funzionalità, ma possono assumere in modo flessibile altri compiti e accogliere altre possibilità di realizzazione.
Una dipendenza infantile dal sistema chiuso deriva, a mio avviso, dalla paura della libertà. La stessa paura che fu del popolo d’Israele, in quanto richiede un esodo dalla schiavitù. Parole chiave: equilibrio, programmazione, integrazione, prevedibilità, potenza, possibile, scambio, zelo, impegno, responsabilità.
Di fianco e non di fronte: l’incapacità di abitare il conflitto
Essere di fianco è agire una mimesis, assumere una postura mimetica che non espone laddove non si può piegare o assorbire la realtà a sé. L’indifferenziato inteso come conformazione ad un dato, che consente il non darsi. Essere di fronte è esplicitare la frattura, la distanza, l’irriducibile differenza.
Identità per Heidegger è essere con sé lo stesso. Una unità di sé con sé che chiede una costruzione in quanto non ricevuta come un tutto senza incrinatura. È un porsi di fronte a sé. Secondo il filosofo tedesco ciò che distingue l’uomo dalle altre forme viventi o naturali è il suo essere aperto all’essere in quanto pensante, di corrispondere all’essere davanti al quale si situa. Di fronte a sé, di fronte agli altri e alle cose. La filosofa Irigaray riprende questo assunto e lo estende in termini di corrispondenza e co-appartenenza: l’uomo sarebbe il luogo di tale corrispondenza e ciò a cui corrisponde è l’uomo stesso. Per cui l’uomo può sperimentare una co-appartenenza fra le cose e lui.
“Provare questa co-appartenenza presuppone di abbandonare il pensiero rappresentativo e lasciarsi andare alla co-appartenenza all’essere che già ci abita, ci costituisce, ci circonda. Presuppone, in effetti, di arrestarci ‘laddove già veramente siamo’”. (Irigaray, 51)
Fronteggiare, affrontare, presuppone il conflitto. L’energia unitiva e distruttiva di cui la dimensione infantile ha timore. Ed esercita la sua paura o aggredendo o regredendo. Il tema del conflitto è, in molti ambiti della vita ecclesiale, visto culturalmente come qualcosa di sbagliato, paragonandolo di per sé al peccato, al male.
Siamo figli del vuoto. Dell’atto di separazione originario. Dall’Adam, dall’uno, si diviene Adamo ed Eva, l’altro che mi è faccia a faccia, l’irriducibilmente altro, l’alterità. Figli di quella ferita, di quello strappo. Come un Adamo cerchiamo di ridurre la distanza, di ricucire la ferita nel dire l’altro/a. O come Caino eliminarla. Evitamento del vuoto, evitamento che l’altro possa dirsi e porsi di fronte a noi. Chiede tempo, chiede attesa. Attendere è farsi raggiungere da una chiamata che non viene da sé ma dall’altro/a.
Collusione/fusione relazionale-emotiva è annullamento della ferita, dello spacco. Per non essere presi dall’angoscia. Paura di un vuoto senza nome, innominabile, non possedibile. La parola entra come manifestazione della frattura. Cerca di edificare un ponte che è annullamento della distanza, via di accesso/eccesso e recesso.
Questa tensione è emersa anche nel dibattito di in una delle assemblee sinodali italiane (2025): è stato messo in discussione il termine ‘accompagnamento’ preferendogli quello di ‘affiancamento’. Quale è l’espressione giusta? Nessuna delle due e tutte e due. Assumere una espressione al di fuori del contesto serve a poco. Così come assolutizzare un termine rispetto ad un altro. C’è il rischio di un condizionamento ideologico: un sistema di idee conchiuso al suo interno che tende affermarsi in contrapposizione ad un altro.
Il termine ‘affiancare’ è stato proposto in alternativa a quello di ‘accompagnare’ per evitare di cadere nella distinzione tra chi sa e chi non sa, tra chi è abilitato e chi non lo è, tra chi è nel giusto e chi nel torto, tra chi detiene un’autorità e chi no. Il primo è l’accompagnatore e il secondo colui che viene accompagnato. Al di là di una visione riduttiva di questa espressione, il ridurre e lo stigmatizzare tipico del pensiero ideologico, questa posizione è comprensibile quando associata al rapporto tra la Chiesa e le donne, o le coppie irregolari o le persone LGTB+. Si scorge una modalità paternalistica, mentre il porsi ‘di fianco’ comunica il condividere alla pari un cammino, una crescita comune, una reciprocità e un dialogo generativo. Al di fuori di questa caratterizzazione, tuttavia, risulta troppo facile usare l’espressione ‘affiancare’. Sembra suggerire una neutralità che non esiste. Una indifferenziazione che non è sana. Gesù procedendo verso Emmaus non affianca ma accompagna. Filippo non affianca l’eunuco ma lo accompagna. Accompagnare è saper mettersi a fianco, dietro, a tratti anche avanti. Farsi compagni implica compromettersi.
Un processo di cambiamento non può essere semplicemente affiancato. I processi di riforma si accompagnano non si affiancano. Occorre, da parte di chi ha una autorità, definire delle condizioni, fornire degli strumenti, dei setting di lavoro, a volte pronunciare anche dei ‘no’, perché è chiesto di mettere in atto un’uscita da un modello per essere iniziati ad un nuovo contesto.
Abitare la tensione non vuol dire sostituire un’espressione con un altra, vuol dire poter disporre di due termini tra cui scegliere dopo un discernimento, valutandone l’opportunità caso per caso.
Qui emerge la dipendenza dalla paura della solitudine. Questo porta a preferire una vita gregaria. L’essere parte di un gregge. Di un corpo unico. Dentro una visione organicistica rassicurante, in quanto in essa tutto si muove in modo coordinato e naturale. Senza vuoti, senza fratture. Parole: corpo, unità, identità, fraternità, affiancare,….
– – –
Queste tensioni hanno forti implicazioni sulla vita ecclesiale rispetto alle relazioni comunitarie, i processi decisionali, la formazione, la visione della realtà. Questi temi saranno oggetto di prossimi articoli. È necessario riequilibrare la tensione, non negando un polo a favore dell’altro – schiacciamento ideale e quindi mortifero -, ma ridefinendo la misura che determina il rapporto tra di essi. Solo in questo modo sarà possibile far uscire i soggetti e le istituzioni da alcune forme infantili di dipendenza. Il tema di fondo è quello di ritrovare dinamiche di libertà. Solo attraverso la libertà si giunge alla responsabilità. Alla costruzione lenta e faticosa del soggetto. La verità ci rende liberi, non felici! La libertà ci pone dentro uno spazio nel quale dischiuderci e non da occupare.

[…] cristiana, ma si limiterà ad analizzare, alla luce delle tensioni introdotte nel precedente articolo, un modo infantilizzante di rapportarsi alla persona. Un approccio infantile non contenuto nella […]
[…] seguente capitolo analizzerà, alla luce delle tensioni introdotte nel primo articolo di questa serie, un modo infantilizzante alle relazioni e alla […]